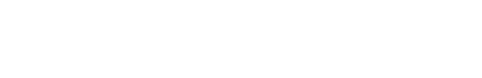Progetti speciali
Sistema di invasi sul fiume Paglia di cui al Piano nazionale degli interventi nel settore idrico - “Sezione invasi” (art. 1, comma 516, legge 205/2017)
AUBAC è Soggetto attuatore della Progettazione di fattibilità tecnica ed economica dell’intervento denominato “Sistemi di invasi sul Fiume Paglia”, finanziata con i fondi del 1° Stralcio del Piano nazionale degli interventi nel settore idrico – “Sezione invasi” (articolo 1, comma 155, della Legge 145/2018), di cui all’Allegato 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17.4.2019.
Fondo per la Progettazione di fattibilità tecnico economica di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità, coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (DM MIMS n. 259/22)
AUBAC è soggetto beneficiario del finanziamento, disposto con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 259 del 29 agosto 2022, finalizzato alla predisposizione di Progetti di fattibilità tecnico ed economica di infrastrutture idriche di particolare rilevanza ed entità, coerenti con gli obiettivi del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico.
Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 - Asse 1 - Linea di Azione 1.1.1 - Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera (POA ALLUVIONI)
Nell’ambito del Piano Operativo Ambiente - Progetto “Misure di prevenzione tese a supportare ed ottimizzare la pianificazione di gestione e la programmazione e realizzazione degli interventi di cui ai Piani di Gestione Rischio Alluvioni, di cui ai fondi FSC 2014-2020, (cosiddetto “POA ALLUVIONI”), AUBAC è soggetto attuatore per la realizzazione delle previste attività.
Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 - Asse 2 - Linea di Azione 2.3.1 - Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici (Progetto ACQUACENTRO)
Nell’ambito del Piano Operativo Ambiente, Progetto “Interventi per il miglioramento della qualità dei corpi idrici”, AUBAC è soggetto attuatore per la realizzazione delle attività finalizzate al potenziamento del quadro delle conoscenze, l’implementazione di misure dirette al miglioramento dello stato di qualità dei corpi idrici, la razionalizzazione dell’utilizzo della risorsa idrica, nonché l’incremento dell’efficienza dei servizi idrici.
Programma manutenzioni stralcio annualità 2018 (Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 332/2018)
Nell’ambito del Programma manutenzioni stralcio annualità 2018, AUBAC è soggetto attuatore ai sensi dell’Accordo di Programma, stipulato in data 13 maggio 2019 con la Regione Lazio per la realizzazione di interventi di manutenzione su sei corsi d’acqua del reticolo idrografico nel territorio di Roma Capitale.
Progetto LIFE Blue Lakes
AUBAC è partner del Progetto LIFE Blue Lakes finalizzato a ricercare e sperimentare soluzioni operative per affrontare l’inquinamento da microplastiche nelle acque ed in particolare nei laghi, combinando attività di governance, formazione, informazione, partecipazione e sensibilizzazione, in sinergia con la strategia dell’UE.
Accordo ex art. 15 della legge 241/1990 con il Commissario Straordinario di Governo Sisma 2016
Con Ordinanza n. 13 del 31 dicembre 2020 il Commissario Straordinario di Governo ha disposto la stipula di uno specifico accordo di collaborazione con l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale per la revisione degli areali a pericolosità da frana elevata (P3) e molto elevata (P4) interagenti con le previsioni di ricostruzione, attraverso la elaborazione di un quadro conoscitivo aggiornato da recepire da parte della medesima Autorità per l’aggiornamento dei Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI) sul territorio delle aree interessate dal sisma del 2016 e 2017, con la successiva condivisione delle Regioni
Programma manutenzioni stralcio annualità 2019 (DPCM 20 febbraio 2019). Interventi di manutenzione in attuazione della pianificazione di bacino del Distretto Idrografico dell'Appennino Centrale – “MANUTENZIONI 2019”
Nell’ambito del Programma manutenzioni stralcio annualità 2019, AUBAC è soggetto beneficiario di fondi per specifici interventi su corsi d’acqua dei bacini idrografici dell’Appennino Centrale all’interno delle regioni Lazio, Abruzzo, Umbria, Marche e Toscana.
Progetto Restart
Nel settembre 2018 l’Autorità di bacino ha stipulato con l’Agenzia per la Coesione Territoriale una convenzione recante la regolamentazione dei rapporti di attuazione, gestione e controllo relativi al Progetto “ReSTART: Resilienza Territoriale Appennino centrale Ricostruzione Terremoto”, CUP D26C18000350006, ASSE 2 - Obiettivo Specifico 2.1 Azione 2.1.1 del Programma Azione Coesione Complementare al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020”. La chiusura del progetto è prevista per il 31 dicembre 2023.